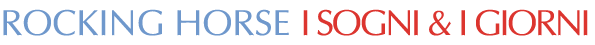IL FANTASTICO RANCH DEL PICCHIO GIALLO
La felicità è un vento leggero e allontana le malinconie che talvolta abitano il cuore. La felicità improvvisa mette le ali ai piedi: la terra sembra il posto delle favole dove i sogni si avverano, la stanchezza non esiste più, tutto ha un senso, le delusioni, le sconfitte, gli errori, diventano di colpo i passi che dovevamo compiere per arrivare all’estasi di quel momento.
Scendevo per via Appiano, in direzione di piazza Giovenale, e avevo la sensazione di non essere più soggetto alla legge di gravità. I miei piedi toccavano l’asfalto del marciapiede ma le gambe, il busto, le braccia e la testa era come se scivolassero senza peso sospinte da un’aria, da una forza invisibile. Ero appena uscito di casa alla notizia che il mio testo era stato preferito a quello di Franco Migliacci e mi sentivo come un ragazzino che dribbla e porta via la palla a Diego Armando Maradona: avevo vinto la competizione con l’autore di “Volare”.
Olimpio aveva scelto la musica per “Il Fantastico Ranch del Picchio Giallo” e per le parole aveva deciso di mettere in gara me e Migliacci, come dire Davide contro il gigante Golia. Ma non possedendo io la furbizia del pastorello ebreo mi buttai nel match con l’incoscienza del principiante e da subito qualcosa nella melodia e nell’allegria del ritmo mi dispose in uno stato di serenità. Scrivevo e non avvertivo l’ansia della sfida. Anzi, quando mi accorsi dopo le prime due strofe che il testo filava via in perfetta armonia con la musica iniziai a giocare con le parole e con i nomi insoliti dei personaggi inventando a raffica immagini e situazioni paradossali. Solo dopo aver messo il punto all’ultimo verso mi ricordai di un simpatico toscano con i capelli sale e pepe, il viso aperto e i modi affabili, sempre vestito in modo impeccabile che da almeno venticinque anni con i suoi versi saliva ai primi posti della Hit Parade; un simpatico signore che molto difficilmente si sarebbe lasciato superare da me: Franco Migliacci. E da quel momento iniziai a temere per la sorte del mio “Picchio Giallo”. Fino a quando la telefonata di Olimpio mi liberò finalmente dall’ansia: i Rocking Horse avrebbero cantato il mio testo.
Le gare per aggiudicarsi una sigla erano frequenti ma non avvenivano per ogni cartone di cui la RCA aveva l’esclusiva. Diventavano invece un passaggio obbligato quando il cartone era destinato alla RAI o a un’altra emittente che rispettava il diritto d’autore. In quel caso Olimpio, autorizzato dal responsabile delle Edizioni, per evitare polemiche o accuse di favoritismo indiceva una maxi riunione alla quale erano invitati nomi illustri e sconosciuti del mondo musicale. Nei primi anni ottanta gli unici soldi sicuri delle sigle provenivano dalla vendita dei dischi poiché nessuna televisione privata pagava i diritti S.I.A.E.. Per il resto ci si doveva accontentare della gloria, a volte tanta, come nel caso di “Candy Candy”. Con la gloria però non ci si paga la benzina, l’affitto di casa o gli altri beni di cui anche gli artisti hanno bisogno. Pertanto quando si seppe che “Il Fantastico Ranch del Picchio Giallo” sarebbe finito a Tele Montecarlo che al pari della RAI rispettava il diritto d’autore la RCA lanciò la gara per la sigla.
Anche Jimmy Tamborrelli presentò un brano ma Olimpio era rimasto affascinato fin dal primo ascolto dal provino di Roberto Rossi, una melodia scanzonata e accattivante che evocava lo spirito festoso di “Ob-la-di, Ob-la-da” dei Beatles. La strofa però lasciava a desiderare, come una bella promessa rimasta incompiuta a metà. Così Olimpio riconvocò Rossi in ufficio e fece in modo che ci capitassero anche Jimmy e Dougie. Il fiuto del produttore intuiva che la soluzione sarebbe arrivata più facilmente e in tempi rapidi mettendo insieme l’estro giocoso di Rossi, la professionalità di Jimmy e l’astuzia creativa di Dougie. Alla fine dell’incontro fu decisa la realizzazione di un secondo provino e i tre vennero spediti in ritiro al “Cenacolo”, una dependance della RCA sulla via Nomentana.
Quando sono costretto a percorrere in macchina quell’anello infernale d’asfalto intorno a Roma che è il Grande Raccordo Anulare, nel punto in cui il cavalcavia incrocia la via Tiburtina mi viene un po’ da star male vedendo ciò che resta degli uffici e degli studi della RCA Italiana. Fino a poco tempo fa scritte cubitali e disegni senza grazia pubblicizzavano un ingrosso di scarpe e stivali imbruttendo la facciata e il tetto di un edificio che fu il tempio della musica e dei sogni di generazioni di ragazze e ragazzi che con le canzoni di quella casa discografica si erano conosciuti, innamorati, sposati ed erano anche invecchiati.
Non riesco a rimanere indifferente di fronte all’aspetto e alla destinazione d’uso di un luogo che dalla fine degli anni cinquanta alla metà dei novanta ospitò e consacrò al successo artisti tra i più significativi della musica leggera italiana. Un luogo quasi sacro per me, una basilica profana nelle cui navate – corridoi, sale riunioni, passi carrabili e aree di parcheggio – immagino i ritratti e le statue di Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Luigi Tenco, Gianni Morandi, Renato Zero, Rita Pavone, Umberto Bindi, Patty Pravo, Ivano Fossati, Paolo Conte. E poi ancora quelli di Riccardo Cocciante, Rino Gaetano, Stefano Rosso, Ivan Graziani, Angelo Branduardi, Amedeo Minghi, Anna Oxa…
Raccontando di “Lulù, l’angelo tra i fiori” ho accennato al bar interno al fabbricato che comprendeva le sale di registrazione. Uno spazio lungo circa quindici metri e largo non meno di otto con il bancone che arrivava quasi fino in fondo. Di fronte al bancone c’era una fila di divanetti in pelle colorata che accoglieva i clienti meno frettolosi e le loro discussioni. Sulle pareti spiccavano le copertine incorniciate dei long playing di maggiore successo. Al centro della sala, a interrompere la sequenza dei divanetti, c’era il juke-box con i 45 giri della casa e della concorrenza. Con una moneta da cento lire si ascoltavano tre canzoni, una sola con una da cinquanta.
In quel bar, dove con l’emozione del fan avevo ammirato da vicino molti degli artisti appena ricordati, ci tornai un’ultima volta nel 1990 per incontrare proprio Franco Migliacci che stava producendo un album di canzoni italiane per Manuel Mijares, un cantante sudamericano che da noi non avrebbe ripetuto il successo raccolto in patria. Migliacci, con il quale avevo già lavorato nel 1986 scrivendo alcuni testi per Scialpi, voleva da me le parole di un brano per Mijares e per il nostro appuntamento avevamo scelto il bar, che all’occorrenza diventava con i suoi divani un ufficio comodo e gratuito. Tornai alla RCA in tutt’altra veste molti anni dopo, intorno al 2000, quando avevo smesso già da tempo la mia attività di paroliere. Ero diventato sindacalista e per gli imperscrutabili disegni del destino il responsabile della federazione, all’oscuro del mio passato artistico, mi aveva affidato una trattativa che riguardava gli operai e gli impiegati del magazzino dove i dischi e le musicassette venivano confezionati e stoccati. Lontana dai successi economici degli anni d’oro, la RCA stava ristrutturandosi e il suo consiglio di amministrazione aveva deliberato di cedere a terzi le attività di magazzino dipendenti compresi.
Mentre in via S. Alessandro varcavo il cancello attraversato per tredici anni, prima con la Dyane arancione e poi con la Polo rossa acquistata in contanti grazie alle sigle dei cartoni, pensai al caso che mi riportava dove avevo deciso di non tornare mai più quando, arreso all’evidenza dei miei limiti, avevo abbandonato la musica. A disagio mi guardai intorno mentre mi accompagnavano all’assemblea sindacale. L’atmosfera era surreale. Quasi nessuno in giro per i vialetti interni e sui piazzali del parcheggio. Poche automobili e troppo silenzio. Ancora qualche passo e capii che i lavoratori del magazzino erano nel bar e che lì si sarebbe tenuta l’assemblea. Aprii la porta a vetri, entrai e mi bastò un’occhiata. Non c’era più niente, solo uno stanzone polveroso, sporco e con poche sedie su cui non sedeva nessuno perché erano più sudice del pavimento. I lavoratori, una quarantina, stavano in piedi ammassati nell’angolo dove un tempo finiva il bancone e c’era la cassa, davanti alla quale quasi vent’anni prima Dougie aveva saputo della morte di John Lennon.
Uscendo dal cancello di via S. Alessandro si girava a sinistra e fatte poche decine di metri si prendeva una stradina molto stretta in mezzo ai prati della campagna romana. In certi tratti occorreva andare piano perché la circolazione era a doppio senso di marcia e non c’era lo spazio per due auto. Nel caso ci si doveva fermare, guardarsi negli occhi e accordarsi con un cenno del capo su chi sarebbe passato per primo. Poi, superate le strettoie, in pochi minuti a media velocità si arrivava al “Cenacolo”, al civico 1111 impresso su una delle due colonnine di mattoni rossi tra le quali si passava dopo aver lasciato la via Nomentana.
Di quel posto ho conservato nella memoria un’immagine verde, verde come l’erba ai lati del viottolo asfaltato oltre le colonnine, come i pendii e le collinette coperte di papaveri, di spighe e di trifoglio. Qua e là come grossi dadi adagiati sul primo spiazzo alla fine di un declivio sorgevano delle costruzioni a un piano, piccoli casolari immersi nel silenzio spezzato solo dal frinire delle cicale o dal cinguettio degli uccelli sugli alberi. In ognuno di quei casolari c’era un piccolo studio di registrazione.
Il “Cenacolo” era il luogo ideale per chi voleva isolarsi per un giorno o per un mese con il suo progetto musicale, da sperimentare e affinare fino al compimento dell’idea creativa. Proprio ciò che fecero, su indicazione di Olimpio, Dougie, Jimmy e Roberto Rossi per completare la scrittura e abbozzare l’arrangiamento del “Fantastico Ranch del Picchio Giallo”. Fu Dougie a trovare, con Roberto Rossi, il motivo vincente per la strofa. Jimmy, contagiato dall’atmosfera bucolica del luogo, ammorbidì per una volta la vena rockettara a favore di sonorità più country. Insomma, meno metallo e più campagna, come del resto richiedeva l’ambientazione della serie. Il provino, nato dal ritiro sulla via Nomentana e dall’intuizione di Olimpio, fu riversato sulla musicassetta che mi sarebbe stata consegnata per la stesura del testo.
Dougie, al pari di Jimmy, è un gran lavoratore della musica, ma ogni tanto ha bisogno di fare casino, di mettersi al centro dell’attenzione, coinvolgendo tutti quelli che gli stanno intorno. Il suo numero preferito è l’imitazione del papero più famoso al mondo: “Donald Duck”, “Paperino”, e può arrivare in un momento qualsiasi, nel mezzo di una discussione o in una pausa, quando dopo tante ore di studio ci si allunga sui divani della regìa. Al “Titania” cambiò genere e si esibì a microfoni aperti nel momento in cui, sulla base musicale che andava nelle cuffie, stavano per essere registrati i cori. Per l’occasione davanti al microfono e pronto a cantare c’era anche Olimpio con Claudia Arvati.
Silenzio totale, visi concentrati, gambe e bacini che ondeggiavano a tempo. L’introduzione era un misto di campanelli, suoni d’ambiente e versi di animali in sottofondo alla melodia di un pianino, mentre il ritmo della batteria cresceva in progressione per lanciare la strofa… E “Vrooooooooommm!!!” La voce di Dougie esplose in un rombo da motore di formula uno al passaggio sotto le tribune. “Vrooooooooommm!!!…” e come un’eco passò anche la prima delle macchine inseguitrici. Poi tornò il silenzio ma solo per un attimo, prima del boato di risate che costrinse il fonico a interrompere la registrazione. Olimpio, l’ho scoperto in questi mesi, è anche un collezionista di momenti felici. Disse al fonico di riportare il nastro in testa e di registrare i cori su un’altra traccia, per non cancellare quell’esibizione estemporanea di cui conservò il ricordo su una copia per uso personale. Così quando ci ritroviamo e abbiamo voglia di rievocare i tempi andati con un bicchiere di bianco o con un brandy ci può capitare di riascoltare quei pochi secondi di improvvisa allegrissima follia.
Follia poetica, quasi un concentrato di cento favole e leggende era la serie del “Fantastico Ranch del Picchio Giallo” tratta dai racconti di Monteiro Lobato, il più importante scrittore brasiliano per ragazzi. Non si trattava di un cartone animato bensì di un mix di personaggi bizzarri, fiabeschi, in carne e ossa o disegnati le cui incredibili storie si intrecciavano sulla scena di un ranch straordinario pieno anche di animali.
“Al Fantastico Ranch del Picchio Giallo niente è impossibile o assurdo e i suoi abitanti non si meravigliano mai di fronte a nulla. Tutto qui è “naturale”, “logico e normale”. Oggetti che parlano; una bambola di pezza che parla e pensa come una vera bambina. I vestiti non sono fatti di stoffa, ma di colore, e sono tagliati con le forbici dell’immaginazione, cuciti con l’ago della fantasia e con il filo del sogno.
Nessuno trova a che ridire se un maialino porta il titolo di Marchese e una pannocchia di granturco quello di Visconte…
Le persone e le cose possono diventare più grandi o più piccole a piacimento e i personaggi appaiono e scompaiono con la stessa naturalezza con cui, nella vita reale, s’incontrano o si lasciano gli amici. Tutti, adulti e ragazzi, animali ed oggetti, si muovono liberamente e con la massima disinvoltura in questo magico mondo.
Basta esprimere un desiderio, anche il più assurdo, per vederne materializzarsi l’oggetto, senza alcuna meraviglia, proprio come fanno i bambini quando, con la loro fantasia, “vedono” le cose più irreali.
Nel mondo del Ranch del Picchio Giallo non esistono né il tempo né lo spazio; non c’è passato né futuro. In un batter d’occhio ci si può ritrovare sulla luna o nell’antica Roma. Esiste solo il presente, in questa irreale realtà dove regna assoluta la fantasia.”
Fu con l’aiuto di questo riassunto della casa di produzione che riuscii a elaborare il testo della sigla. Martedì 7 aprile 1981 ultimato il missaggio poco prima di mezzanotte lasciavo il Titania, contento del lavoro compiuto e soddisfattissimo per i risultati raggiunti in studio da Jimmy, Dougie e compagni. Un altro brano dei Rocking Horse stava per andare in televisione e questa volta oltre ai soldi per la vendita dei dischi potevo finalmente aspettarmi un guadagno in più grazie ai diritti d’autore per le trasmissioni di Tele Montecarlo.
Lavoro, progetti, speranze. Il 1981 era iniziato bene e proseguiva nel migliore dei modi. Fu l’anno in cui scrissi “Conan” per Georgia Lepore e “Gordian” per i Superobots. In tutto riuscii a pubblicare quattordici brani; un buon successo per un giovane paroliere ancora nella fase dell’apprendistato. Ricevevo proposte di collaborazione una dopo l’altra e benché la maggior parte delle mie fatiche andasse sprecata – almeno tre testi su quattro restavano inediti o venivano scartati – ogni volta che vedevo il mio nome sull’etichetta di un disco mi arrivava una sferzata di energia sufficiente a farmi dimenticare in un attimo la parte del sogno che non si era avverata. Scrivevo e guardavo avanti, al domani, a un’idea, a un colpo di fortuna che avrebbe potuto cambiarmi la vita. Anch’io come Jimmy, Dougie, Olimpio e tutti gli altri, correvo da uno studio di registrazione all’altro. Ero in contatto con diverse case discografiche e il giro delle conoscenze si arricchiva ogni mese di nuovi nomi, nuovi autori, editori, cantanti e gruppi. Dovetti comprare un’agenda per segnare appuntamenti e numeri di telefono.
Per qualche mese non pensai più al “Fantastico Ranch del Picchio Giallo”. Aspettavo di essere chiamato dalla RCA per la firma del bollettino di deposito alla SIAE e del contratto di edizione. Sarà il mese prossimo, mi dicevo, sarà quando sarà. Avevo già sperimentato con altre canzoni che i tempi di pubblicazione potevano slittare per una ragione qualsiasi di un mese o di due o più ancora.
Poi seppi la verità. Del mio testo che aveva superato sul filo di lana quello di Franco Migliacci, dell’inventiva musicale di Dougie che nella pace del “Cenacolo” aveva risolto l’empasse delle strofe, della creazione di Roberto Rossi, dello splendido arrangiamento di Jimmy Tamborrelli e delle perfette sessioni al “Titania” condite dagli scherzi di Dougie non se ne sarebbe fatto più nulla.
I palinsesti di Tele Montecarlo in quel periodo erano particolarmente affollati e così “Il Fantastico Ranch…” fu messo in onda a orari impossibili per un ascolto di massa. Fu un flop. Colpa dell’orario, colpa dei contenuti troppo astrusi o del disorientamento dei telespettatori di fronte a una storia interpretata contemporaneamente da attori veri e da personaggi animati, colpa di uno spettacolo di tipo nuovo, forse in anticipo sui tempi, troppo in anticipo per essere gradito dal pubblico. Dopo due settimane di programmazione Tele Montecarlo decise di ritirarlo dagli schermi e la RCA sospese la stampa e l’uscita del disco. Ricostruendo i fatti con Olimpio ho saputo di altre dieci sigle che in quegli anni subirono la stessa sorte. All’epoca, preso com’ero dal susseguirsi degli impegni che non mi lasciavano il tempo di riflettere o di immalinconirmi per qualche vicenda sfortunata, feci poco caso all’accaduto. Pensai distrattamente a una battuta d’arresto, a qualche complicazione che prima o poi si sarebbe risolta. Come ho detto, scrivevo e guardavo avanti. Del resto non riuscivo a immaginare che si potessero spendere alcuni milioni di lire per produrre una canzone e poi lasciarla nel cassetto…
“Il Fantastico Ranch del Picchio Giallo” rimase inedito. Fortunatamente prima di lasciare il Titania avevo ottenuto una copia su musicassetta del missaggio finale. Mi ero talmente innamorato di quella sigla e di tutti i bei momenti vissuti durante la lavorazione che mi dispiaceva aspettare chissà quanto prima di poterla riascoltare dal disco. Così per un quarto di secolo sono rimasto uno dei pochi a possedere una copia dell’originale, e l’ho custodita gelosamente come prova innegabile della veridicità di quanto asserì Claudio Balestra una sera che insieme con lui e i suoi fratelli consideravo le incognite e le difficoltà del mestiere della musica. “Lucio” mi disse “finché non vedo il mio nome stampato sopra quel coso circolare con il buco in mezzo, non sono mai sicuro d’avercela fatta!”.
E può anche succedere di riuscire a vedere il proprio nome stampato sul disco e che poi di quella cosa circolare con il buco in mezzo se ne vendano cinquecento o mille copie al massimo. Al momento della chiacchierata con i fratelli Balestra, nel parcheggio sotto il cavalcavia del Grande Raccordo Anulare, non avevo ancora provato l’esperienza di guadagnare poche decine di migliaia di lire con un testo. Giusto i soldi per la benzina, dopo avere attraversato più volte la città, dopo interminabili attese per un’audizione di un quarto d’ora, pieno di sonno a mordendomi la lingua per non mandare a quel paese un cantante che faceva il difficile o un produttore che si approfittava della mia voglia di arrivare.
Disavventure e belle sorprese della vita, cose che non ti aspetti e che arrivano perché il mondo è complesso e tutto fa parte del gioco dei sogni e dei giorni, come Corrado Paganelli.
Corrado è un fan della primissima ora che, unendo la passione per i cartoni e per le sigle allo spirito di iniziativa, da anni promuove attività che incontrano l’interesse di molti suoi coetanei producendo, per esempio, DVD, CD e vinili per i collezionisti. Nel 2006 mi ha intervistato e nel 2012 ha voluto incontrare Olimpio, Dougie e me per regalarci l’Opera Omnia dei Cavalieri del Re di cui ha curato la produzione artistica insieme a Riccardo Zara.
Il 4 luglio 2015 avrebbe voluto rivederci a Firenze dove ci attendeva un gruppo di iscritti all’associazione di cui è socio fondatore ma ho dovuto declinare l’invito per motivi personali e Corrado ha affidato a Olimpio un dono per me: il 45 giri del “Fantastico Ranch del Picchio Giallo” stampato dopo più di trent’anni dall’etichetta che fa capo all’associazione!
Più di trent’anni. Un mare di tempo nella vita di un uomo ma poco più di niente nella storia dell’universo. Basta cambiare il punto di osservazione, il contesto, e ciò che era stato motivo di malinconia diventa l’occasione per dire grazie a un amico
“Sono solo canzonette”, cantava Edoardo Bennato. E Jimmy Tamborrelli sembra fargli eco con una delle sue perle di saggezza: “Io dico sempre a tutti: è musica leggera! Non è Beethoven quello che facciamo. C’è la strofetta, l’inciso e poi adesso c’è anche il bridge, un’invenzione musicale in più, un extra che rilancia il motivo proprio quando sembra che sia finito. Ma è sempre musica leggera. Leggera! Non è Beethoven!” Come per dire: diamoci una regolata, noi con le nostre arie da geni incompresi e le nostre creazioni.
I grandi hanno sempre ragione. E Jimmy è un grande per la freschezza delle composizioni e degli arrangiamenti, per la semplicità d’animo e la serenità con cui vive il successo e i momenti di lavoro senza clamore. Quando arriva ti colpisce la tranquillità del sorriso. Un sorriso di pace, aperto, senza sottintesi, lo stesso che illuminava il viso di Rino Gaetano nella calura di un pomeriggio del 1980.
Stavo aspettando qualcuno sulla porta di ingresso degli studi. Fumavo e osservavo il viavai di artisti e funzionari. Spuntò dal vialetto che portava ai magazzini e alla mensa, il passo leggero nelle scarpe da ginnastica, alto, magro magro, un paio di jeans e una camicia che si gonfiava con lo scirocco. L’avevo riconosciuto e me lo guardavo di gusto perché prima di essere autore ero soprattutto un fan nell’Olimpo dei cantautori; e Rino Gaetano era per me uno speciale, uno che cantava le cose più serie nel modo più divertente. “Il cielo è sempre più blu”, “Mio fratello è figlio unico”, “Berta filava”, “Nun te regghe più”, “Gianna”, le avevo consumate a furia di sentirle.
Forse si era accorto di essere osservato e aveva intuito le ragioni della mia attenzione un po’ sfacciata. Proseguì serafico e quando mi fu a un passo, mentre varcava la porta a vetri girò la testa dalla mia parte e mi regalò un sorriso. Volò via dalla RCA, dalla musica, da Roma e dalla vita, all’improvviso, per un incidente stradale all’alba del due giugno, mentre i traghetti partiti da Civitavecchia e da Livorno erano ormai in vista delle coste della Sardegna, carichi di ragazzi e ragazze, di famiglie, di nonni e di bambini che andavano incontro all’estate del 1981.