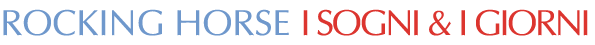MYSHA
Alle ore 10,00 del 24 novembre 1980 Dougie, Mike, Dave, Mick e Derek attraversarono l’ingresso del Telecinesound, lo studio romano preso in affitto dalla RCA per realizzare “Mysha”.
Perché era passato quasi un anno prima che Olimpio decidesse di mandare nuovamente in campo i Rocking Horse? E perché anch’io non ero stato più chiamato per scrivere il testo di una sigla? Perché si creò un vuoto di molti mesi tra “Candy Candy” e “Mysha” nella vita dell’unico gruppo rock nella storia delle sigle della tivù italiana? Forse perché il nome del gruppo era stato inventato solo per rispondere alla necessità di un momento?
Erano state incise due canzoni; una per un cartone animato, “Candy Candy”, e l’altra per una vecchia serie di telefilm in bianco e nero, “Lucy”, la prima realizzata da una squadra di professionisti della musica, la seconda da due fratelli compositori e valenti strumentisti che secondo il progetto avrebbero dovuto interpretare anche la prima. Il prodotto finale però consisteva in due brani di sapore del tutto diverso la cui unica componente comune erano i due testi creati da me a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. L’editore aveva previsto l’uscita delle due sigle come lati A e B dello stesso 45 giri, mancava solo il nome da assegnare agli interpreti. Nome che per logica avrebbe dovuto essere diverso per le due facciate ma che, non so per quale motivo, rimase lo stesso: “Rocking Horse”.
Da gennaio a ottobre del 1980 la febbre delle sigle dei cartoni giapponesi era cresciuta contagiando un gran numero di artisti e produttori, mentre la RCA si era trasformata in parte in una fabbrica di piccoli e grandi successi per le emittenti televisive locali e nazionali. Esistevano dunque molte opportunità di lavoro e chi a fine maggio aveva fatto centro nella Hit Parade meritava sicuramente una chance per restare sulla cresta dell’onda. Invece i Rocking Horse e il sottoscritto furono lasciati in naftalina. Forse nessuno dei nuovi anime in produzione era compatibile con l’impronta sognante del sound, della musica e del testo di “Candy Candy” e Olimpio, colto di sorpresa dal boom di vendite, non volle rischiare di disperdere con una scelta inadeguata quel patrimonio di consensi.
Tra tanti interrogativi senza risposta resta però una certezza: nessuno di noi si sentiva disoccupato. Dougie e Mike, per esempio, avevano già dato vita con altri artisti ai Superobots, un nome e un marchio, più che un supergruppo, con cui venivano identificati cantanti e strumentisti diversi, scelti e messi insieme secondo le necessità del momento dal fiuto e dalla sensibilità del produttore. Infatti mentre i Rocking Horse restavano in letargo i Superobots incidevano “Grand Prix e il Campionissimo”, dove la voce di Dougie, anche se in secondo piano, risultava asciutta e sfrondata di accenti e sdolcinature made in England.
Io, dopo la timbratura del cartellino alle Pagine Gialle e dopo aver percorso in macchina più di mezza città, mi buttavo senza riserve in ogni progetto di canzone. La singolarità dei miei orari di lavoro indusse Mario Vicari, responsabile della realizzazione di “Lucy”, a soprannominarmi “l’uomo delle sei” per il fatto che mi presentavo in RCA quando la maggior parte degli impiegati aveva lasciato gli uffici e cioè intorno alle sei del pomeriggio. Enzo Busi, un amico cantautore, mi fece conoscere Ciro Dammicco, leader dei “Daniel Sentacruz Ensamble” che con “Soleado” avevano venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Con Ciro e con il fratello Stefano nacque una collaborazione che portò alla pubblicazione di due brani: “Donna” e “Nel Cielo”, quest’ultima trasmessa nella diretta RAI di “Domenica In”. Per Fiammetta firmai “Sulla strada”, sigla di “Sereno Variabile”, Radio Rai, e nello stesso anno sempre come paroliere realizzai con etichette discografiche minori altre quattro canzoni per artisti giovanissimi pieni di speranze e entusiasmo. Insomma, ero uno che si dava da fare un casino e di tanto in tanto vedeva avverarsi un frammento del suo grande sogno: vivere unicamente con i soldi che arrivavano dal mestiere della musica.
Per aggiudicarsi la sigla di “Mysha” non fu necessario partecipare a una delle gare micidiali in uso nella RCA di allora. Dougie e Mike prepararono un provino in inglese, un arrangiamento semplice e brillante con il titolo del brano ripetuto ogni capoverso delle strofe, e io per scrivere il testo immaginai un orsetto di peluche, uno di quelli che i bambini tengono sul cuscino per abbracciarselo la sera mentre si addormentano. Poi cominciai a raccontarlo alla mia maniera: tante piccole fotografie fatte con le parole.
“Fiocco di nuvola”, una di quelle istantanee in versi, sembra che evocasse negli adulti, almeno in quelli più maliziosi e dalla fantasia troppo fertile, una nuvola di cocaina. Roba da matti. Io volevo solo suscitare sensazioni di tenerezza ispirandomi a Walt Disney, padre nobile dei cartoni animati e maestro nell’umanizzare ogni forma di vita animale, vegetale o minerale con i sentimenti e le emozioni tipici delle persone. Anche molti anni dopo, scrivendo “L’ora della buonanotte” per Sonia conduttrice di “T.R.E.” ricordai la lezione del grande maestro americano e immaginai i pesciolini di un acquario che sentivano arrivare il sonno allo stesso modo degli esseri umani. Così in una delle strofe mi venne naturale scrivere “nella stanza tutto tace… e nell’acqua i pesci rossi sbadigliano…”.
Alle 19,34 di domenica 23 novembre la terra tremò in tutta Italia per novanta interminabili secondi. In Irpinia la scossa fu distruttiva e mortale. Ancora una volta la durezza della realtà si abbatteva sull’esile architettura dei sogni della gente comune, di quelli che avevano lavorato e risparmiato per costruire o comprare una casa destinata a crollare in un tuono sordo e continuo che dopo averla scossa dalle fondamenta la radeva al suolo coprendola sotto una nuvola di polvere né soffice né romantica.
La mattina dopo cinque ragazzi, tre inglesi e due scozzesi, salirono con le loro chitarre, la batteria, la tastiera elettronica e i microfoni su una parte minuscola dell’immenso e misterioso palcoscenico dei giorni. Si chiusero in una stanza dai muri imbottiti di lana di vetro e replicarono il miracolo della musica. I Rocking Horse incisero “Mysha” quasi nella loro formazione tipo. Oltre a Douglas Meakin, avviato a diventare l’immagine e la voce simbolo del gruppo, entrò per la prima volta in studio Mike Fraser alle tastiere; e fu la prima volta anche per Dave Sumner alla chitarra e Mick Brill al basso elettrico. Terza volta invece per Derek Wilson, che aveva suonato la batteria anche in “Lucy”.
Il brano fu arrangiato mantenendo la struttura e le sonorità del provino. Qualche anno fa Olimpio si è divertito a confezionare un inedito collage mescolando parti della demo con altre tratte dal disco. Il risultato è sorprendente: le uniche differenze evidenti con il provino casalingo di Mike stanno nella qualità dei suoni registrati in studio e nella ricchezza dei cori, dovuta anche alla partecipazione di Roger Crouch, vocalist di talento che aveva cantato con Dougie al Sistina.
Com’era prevedibile, la pronuncia di Dougie mise in crisi Olimpio, preoccupato dell’esame finale alla ITB. “Mysha” era il primo brano dei Rocking Horse con Dougie nel ruolo di cantante titolare e non di rincalzo dell’ultima ora come in “Candy Candy”. Perciò la responsabilità del risultato era maggiormente sentita sia da lui che dal produttore e fu subito chiaro che i problemi si sarebbero concentrati nel ritornello, pieno zeppo di erre: un vero tallone d’Achille per Dougie, anche se con l’andar del tempo certi difetti divennero una caratteristica delle sue interpretazioni, un segno distintivo molto amato dai fan. “Gli orsacchiotti come te fanno troppe fantasie tanti sogni e poche furberie con le tigri di quaggiù prepotenti un po’ di più, mica buone come sei tu…”. Nel secondo giorno di lavoro questi semplici versi costrinsero Dougie ad ardite acrobazie vocali e Olimpio modificò il testo aggiungendo due o tre erre una dopo l’altra dove la grammatica ne richiedeva una sola, mentre il fonico enfatizzava l’effetto agendo sui cursori del mixer.
La registrazione di “Mysha” fu completata in perfetto orario alle otto di sera di martedì 25 novembre. Venti ore di lavoro comprese le pause al bar in due giorni. Un record.
Bisognava spendere poco, anche perché non ci si attendeva un gran ritorno economico da una serie di soli ventisei episodi dedicati per di più a un pubblico ristretto, quello dei più piccini. Ora la dirigenza faceva economie e pretendeva dischi eccellenti. Douglas Albert Meakin ricordava invece un’altra RCA, quella che quattordici anni prima aveva mandato a Firenze una limousine nera per riportarlo a Roma.
Alla fine del febbraio 1966 Dougie aveva lasciato Liverpool ed era atterrato all’aeroporto di Fiumicino con il complesso dei Motowns e un buon contratto in tasca con la casa discografica romana. Il gruppo inglese girava l’Italia per un tour nei locali alla moda quando il 4 novembre l’alluvione li sorprese a Firenze. L’acqua che aveva invaso la città distrusse gli strumenti e l’amplificazione. I Motowns, bravi ma non ancora popolari né ricchi, erano diventati improvvisamente poveri: avevano perso tutto.
Ripristinate le comunicazioni telefoniche i discografici di via S.Alessandro furono informati dell’accaduto e Ennio Melis, direttore artistico e generale, decise l’invio della limousine che arrivò a Firenze una settimana dopo l’inondazione e riportò nella capitale i giovanissimi artisti. Ma la generosità di Melis e della RCA regalò a Dougie e ai Motowns una seconda sorpresa: fu lo stesso direttore a lanciare una colletta tra i suoi cantanti allo scopo di mettere insieme il denaro per ricomprare la strumentazione rimasta sotto il fango, promettendo che a raccolta ultimata la RCA avrebbe contribuito con una cifra equivalente a quella del totale. Tra i tanti che parteciparono alla gara di solidarietà Dougie ricorda i nomi di Luigi Tenco, Rita Pavone, Gianni Morandi e Jimmy Fontana. Dopo l’acqua dell’Arno, piovvero sui Motowns ben quattro milioni di lire e Dougie e compagni poterono continuare l’avventura musicale. Due anni più tardi maturò nel gruppo l’uscita del leader, Lalli Stott, e la sua sostituzione con Dave Sumner, il chitarrista che da “Mysha” in poi con le evoluzioni della sua sei corde elettrica rese ancora più inconfondibile il sound dei Rocking Horse.
La pubblicazione della sigla, prevista per la fine di dicembre del 1980, subì un ritardo di quasi cinque mesi. La macchina delle sigle guidata da Olimpio Petrossi non si concedeva soste, ma in alcuni momenti le richieste diventavano superiori alle capacità produttive e le stesse case d’importazione dei cartoon non riuscivano a conciliare le loro necessità con i palinsesti delle televisioni private. Ciò provocò lo slittamento della pubblicazione di “Mysha” dalla data prevista alla metà di maggio 1981. Le edizioni musicali, che non facevano molto assegnamento sulle potenzialità commerciali della sigla, decisero di assegnarle la facciata B del 45 giri e come lato A scelsero “Supercar Gattiger” dei Superobots, questa volta con le voci dei fratelli Balestra. Tale particolare confermava che i Superobots erano un grande contenitore di artisti che si alternavano in studio secondo le circostanze.
Per effetto del ritardo accumulato l’uscita di “Mysha” nei negozi di dischi coincise con uno degli avvenimenti più drammatici della seconda metà del ventesimo secolo, l’attentato del 13 maggio a Giovanni Paolo II° in piazza San Pietro. E se fin qui si trattò di una normale coincidenza, l’aspetto singolare di questa combinazione di eventi lontanissimi uno dall’altro riguarda invece lo stesso Olimpio Petrossi cui si deve la produzione e la realizzazione artistica del brano dei Rocking Horse. Fu lui infatti che sedici anni dopo quel terribile evento produsse e realizzò tre CD con le poesie di Papa Wojtyla lette da Vittorio Gassman, Claudia Cardinale, Monica Vitti e Alberto Sordi. Olimpio compose anche le musiche di commento e ne curò gli arrangiamenti.
La sigla dell’orsetto non ebbe un particolare successo di vendite; il marketing RCA aveva fatto bene i suoi calcoli. Ciò nonostante, mentre il singolo originale si attestò sulle tredicimila copie, “Mysha” fu incisa anche da altre etichette e inserita in numerose compilation, prima su vinile e poi su CD, raggiungendo le centodiecimila copie vendute. Un esito più che dignitoso.
Non sempre i buoni risultati si misurano con i numeri, con i soldi, con il posto in classifica o con i download da internet delle vecchie sigle trasformate in suonerie per i cellulari.
C’era una volta Sabrina, una bambina rimasta orfana dei genitori. Aveva quattro anni e viveva in un quartiere popolare di una grande città. Ogni mattina apriva gli occhi nel suo lettino con la trapunta rosa e chiamava la mamma che non poteva più risponderle. La piccola voce attraversava il lungo corridoio, girava l’angolo e dopo aver varcato la soglia di una stanza col pavimento in legno risaliva le pieghe della coperta sotto la quale per tutta la notte nonna Bianca aveva riposato e pianto. Nel silenzio che faceva eco alle sue parole Sabrina si alzava, metteva i piedi nelle pantofole e un passo dopo l’altro arrivava al cesto dei giocattoli. In cima ai birilli di plastica, alla palla, alle bambole, una senza un braccio, l’altra senza vestiti e senza capelli, trovava l’orsetto, ultimo regalo di un giorno in cui era piovuto incessantemente e la casa si era riempita e poi vuotata all’improvviso di persone che s’erano asciugate il viso, gli occhi lucidi, e soffiate il naso mentre i fazzoletti apparivano tra le dita e sparivano nelle borse delle signore e nelle tasche degli uomini. Con l’orsetto per mano entrava dalla nonna e le tirava la coperta. Ancora un fazzoletto che finiva sotto il cuscino. Sabrina non andava all’asilo; era cresciuta giocando con la mamma e i bambini di altre mamme ai giardini pubblici. Non aveva mai abitato con la nonna fino al giorno della pioggia, quando tutti erano andati via e nella casa erano rimaste due anime smarrite che quasi non si conoscevano, poiché Bianca prima d’allora aveva sempre vissuto in un’altra casa, distante centinaia di chilometri. La nonna scendeva dal letto, preparava la colazione, lavava i piatti della sera, riordinava le stanze e acceso il televisore si allontanava per telefonate interminabili e misteriose. Seduta sul divano accanto all’orsetto, Sabrina seguiva le immagini sullo schermo a colori: parole che quasi non comprendeva, luoghi mai visti, centinaia di volti raramente di bambini, cose raccontate da qualcuno che se ne stava seduto dietro un tavolo, vestito bene, con dei fogli di carta davanti. Dopo un po’ tutto cambiava. C’erano uomini che correvano sulle macchine e ne inseguivano altre più veloci, molto più della Fiat 127 che guidava il suo papà; alcuni tiravano fuori un braccio, avevano una pistola in mano e urlavano e si sentivano dei botti e venivano fuori lampi di fuoco e di fumo. Qualcuno doveva essere stato colpito da quei lampi dopo uno scoppio tremendo, aveva piegato la testa sporca di sangue e non gridava più.
Un giorno tutto cambiò davvero. Sabrina iniziò a sentire una musica che le sembrò bella e dolce, che la faceva star bene, vide l’orsetto, il suo orsetto, nello schermo a colori e fu felice di scoprirne finalmente il nome: Mysha!
Ho incontrato Sabrina ai primi di ottobre del 2006. Era sera, stavo uscendo con Olimpio, Dougie e Mike dalla Fiera di Roma dove avevamo partecipato al “Candy Candy Day” ed eravamo stati intervistati, premiati e applauditi come ospiti d’onore. Sabrina si è avvicinata e ha chiesto se poteva fotografarci ed essere ripresa insieme a noi. Poi ci ha ringraziato per le foto e per avere scritto “Mysha”. Era lì per la festa dei fumetti e dei cartoni animati insieme a migliaia di ragazzi e di bambini di oggi e di ieri, tutti ugualmente innamorati dei loro eroi di carta, di celluloide o di pixel.
Ci ha raccontato la sua storia con i grandi occhi ridenti e le mani che disegnavano nell’aria ciò che le parole non riuscivano a spiegare. “Mysha” era il suo anime preferito e la sigla le era rimasta nel cuore. Ci ringraziava ancora per averle tenuto compagnia, per averla fatta sorridere e sognare, per aver reso più lieve il vuoto e la malinconia di una primavera-estate di tanti anni prima, quando era rimasta a vivere con una nonna che non sapeva farle da mamma. Forse perché in quell’incontro imprevisto tutto era andato troppo in fretta, io al contrario non avevo fatto in tempo a esprimerle la mia gratitudine per aver reso più leggero – con la grazia dei suoi ricordi e la generosità dei sentimenti – un peso, una privata malinconia che proprio in quelle ore mi portavo dentro e che in pubblico dovevo dissimulare. Non ero stato pronto a capire il piccolo miracolo, lo scambio involontario di belle energie che ci era capitato.
Una settimana prima, Olimpio e io eravamo stati intervistati da Rai Futura, ospiti di un programma nel quale eravamo stati presentati come “i papà delle sigle anni 80”. A telecamere spente, mentre lasciavamo lo studio due giovani tecnici che avevano seguito la trasmissione dai monitor si sono avvicinati, ci hanno stretto la mano e anche loro hanno voluto ringraziarci per le nostre canzoni. Poi non so come sono rimasto solo con Marco, il più alto, un bel tipo sui trentacinque anni. Un po’ impacciato, forse intimidito, mi ha detto a mezza voce “Signor Macchiarella, le sue parole, quelle che lei ha scritto per la sigla di Conan, per me sono state importanti, mi hanno aiutato… Ho passato momenti molto difficili… più di una volta. Ma quelle parole che parlavano di speranza e della possibilità di ricominciare, di avere un futuro migliore, anche quando tutto ciò che amiamo è andato distrutto e ci sentiamo persi, mi tornavano alla mente, me le ripetevo e mi davano fiducia. Ripensavo al valore di un sorriso e riflettevo sull’importanza dei sogni che ci portiamo dentro, perché i sogni danno la forza di superare gli ostacoli. Insomma, non mi sono arreso. Ogni volta ho ritrovato il coraggio e ce l’ho fatta. Per questo volevo dirle grazie”.
Impreparato a ricevere una dichiarazione tanto disarmante, forte e definitiva perché era di qualcuno che non avrei più rivisto, sono riuscito a stento a replicare che non avevo fatto niente di speciale, che avevo solo scritto delle canzoni. E l’ho salutato con un sorriso imbranato ma con la sensazione, mentre raggiungevo Olimpio, di camminare a un palmo da terra: avevo saputo che almeno una volta nella vita ero stato utile a qualcuno.
A Marco e a Sabrina, se li ritrovassi oggi, direi che dai loro racconti e dalla loro delicatezza d’animo sono stato io a ricevere tantissimo. Qualcosa di diverso dall’entrare in Hit Parade, ma non meno importante.
Con “Mysha” i Rocking Horse percorsero un altro pezzo di strada verso la popolarità, iniziarono a essere riconoscibili, a distinguersi tra i tanti interpreti di sigle per un mix originale di sonorità, arrangiamenti, ritmo e testi che via via li rese unici. Fatalmente cominciarono a essere amati quanto i protagonisti dei loro cartoni animati.
La televisione aveva cambiato volto, non più di tre anni prima, nel 1978, in Italia le trasmissioni erano ancora in bianco e nero. Dall’anno successivo il colore e la rapida espansione delle emittenti commerciali modificarono le abitudini dei telespettatori. Mentre dagli Stati Uniti arrivavano telefilm di nuova generazione come “Dallas”, che dopo un avvio sfortunato in Rai era esploso su Canale 5, l’invasione dei cartoon giapponesi diventava un fenomeno di costume senza precedenti tanto da innescare una competizione, nel gradimento dei più piccoli, con classici dell’animazione come “Cenerentola”, “Lilly e il Vagabondo” o “Biancaneve e i Sette Nani”.
Nel febbraio 1982 un bambino della seconda media di un piccolo paese della provincia di Cagliari, in un compito in classe sulla televisione e sui suoi programmi preferiti, scriveva tra l’altro: “…Quello che ascolto con più interesse sono i cartoni animati come Mysha che mi diverte molto. Già all’inizio c’è una canzone che so a memoria e che ha delle parole facili da imparare e belle, che mi fanno pensare chissà perché a una certa ragazzina. Dice: Mysha fiocco di nuvola, nato da una favola Mysha che tenerezza fai dovunque vai Mysha, caldo batuffolo Mysha che Natascia coccoli Mysha, Mysha più angelo che mai… Per inventare queste canzoni io penso che ci voglia molta bravura, esperienza e sensibilità; a me sembra impossibile come riescano coloro che fanno le canzoni a fare le rime di continuo, io non ci riuscirei mai”.